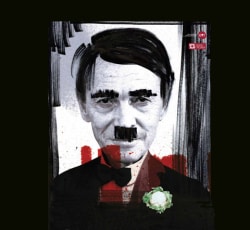Ha intrapreso un lungo viaggio, passando per l’Emilia prima di arrivare alla capitale. Ha vinto uno dei Premi Speciali Ubu 2013, “per l’impegno nel reinventare la funzione sociale del teatro”. Non è solo uno spettacolo. È un percorso laboratoriale. Non prevede solo messe in scena. Ma attiva una rete articolata di attività e una fitta maglia di collaborazioni. È un’indagine, non esclusivamente teatrale, su quello che siamo stati e su ciò che siamo oggi. Ha il patrocinio del Parlamento Europeo, è coprodotto dal Teatro di Roma e da Emilia Romagna Teatro Fondazione, in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, Conservatorio “Santa Cecilia”. È Il ratto d’Europa – Per un’archeologia dei saperi comunitari, da oggi, 29 aprile, e fino all’11 maggio, sul palco dell’Argentina per undici serate. Una drammaturgia collettiva per un’improbabile squadra di nove elementi, chiamata a salvare il vecchio continente. È Claudio Longhi, regista, professore associato in Discipline dello Spettacolo all’Università di Bologna, a ripercorrere con noi le fasi di questo progetto, che ha ideato e diretto, e che ha visto la luce, proprio sul palco dell’Argentina, qualche primavera fa…
«La genesi è radicata ne La Resistibile ascesa di Arturo Ui (portato in scena a Teatro di Roma dal 28 marzo al 29 aprile 2011; qui potete leggere la recensione e qui un’intervista di approfondimento ndr). All’indomani di quell’esperienza, a maggio-giugno, il direttore di Ert, Pietro Valenti, cominciò a chiedermi di ipotizzare una collaborazione futura, che forse avrebbe coinvolto anche il Teatro di Roma. Dopo un incontro ad Avignone, a fine luglio, durante il quale abbiamo riflettuto sulla funzione del teatro pubblico, sul destino della regia, approcciando la questione in termini che definirei squarziniani, ovvero come modo di produzione e non come sintassi artistica, si è usciti con l’idea di pensare un progetto piuttosto che fare uno spettacolo».

Foto Giuseppe Distefano
Quindi nasce il ratto d’Europa?
«Sì, un primo interlocutore per me era Ert, che ha un’attenzione nei confronti dell’estero non comune, che si radica anche in prassi. Penso al Progetto Prospero, a VIE Scena Contemporanea Festival, un humus che portava a guardare verso quegli orizzonti. Poi nell’estate del 2011 cominciava la grande cavalcata dello spread, ogni volta che accendevo la televisione era una geremiade sull’Europa, avevamo perso la sovranità nazionale, c’era il rischio di commissariamento per l’Italia. Si oscillava tra l’emergenza Europa e una sostanziale indifferenza, una sorta di insensibilità rispetto al significato di Europa».
E con l’apertura dell’anno accademico 2011/2012, il tema viene affrontato in ambito universitario, giusto?
«Sì, è mia consuetudine pensare all’università come a un laboratorio dove far nascere delle esperienze, perciò ho dedicato due corsi alle ricadute teatrali del tema Europa, uno a Venezia allo Iuav (ancora non c’era stato il richiamo ufficiale all’Unibo) e uno a Bologna. Un’occasione per riflettere, per osservare la percezione di ragazzi di 25 anni. Intanto si siglavano gli accordi di coproduzione e prendeva corpo il progetto, la cui partenza ufficiale è stata – ahimè un giorno indimenticabile – la mattina del terremoto in Emilia Romagna, nel maggio del 2012, con un primo incontro ufficiale ai giardini pubblici di Modena, perché era pericoloso stare all’interno della Biblioteca Delfini dove avevamo fissato l’appuntamento».
Poi il debutto modenese a maggio 2013 e quello romano nel 2014. Ma non si tratta solo di spettacoli, ci sono una serie di attività collaterali. Allora, come agisce il ratto?
«Si prendono contatti con le realtà più varie e trasversali all’interno del corpo urbano, dai centri anziani alle scuole elementari, dalle comunità religiose ai sindacati. Il ratto offre gratuitamente attori per letture, ad esempio, e in cambio chiede di portare in dote le proprie specificità, il proprio pubblico, le proprie relazioni, e così si disegnano ipotesi di lavoro. Abbiamo inanellato una serie di attività nate sulla base di questi incontri, e contestualmente proposto ai partner di creare dei laboratori di drammaturgia, lo abbiamo fatto con gli esodati a Roma e con i sindacati a Modena. Il ratto ha una vitalità carsica, dovuta ai laboratori, che hanno un’apertura verso l’esterno in termini di presentazione dei testi sul sito, e di messa in scena integrale dei testi scritti, com’è stato a Modena e come sarà qui a Roma, parallelamente al debutto dello spettacolo, con un’idea di rendere il teatro vivibile 24 ore al giorno, e di attivare una riflessione sulla funzione del teatro all’interno delle città».

Un ritratto di Claudio Longhi
Modena e Roma, due cosmi differenti, ma stesse attività?
«L’unica modalità di lavoro squisitamente romana è quella degli atelier, che vede il coinvolgimento di non professionisti, con due giorni di prove su tematiche europee e poi la restituzione pubblica del lavoro. C’è, poi, una differenza di tempi: mentre a Modena il lavoro, iniziato nel 2012 si è concluso nel 2013, a Roma si è svolto nell’arco di due stagioni».
Sul palco dell’Argentina, oltre agli attori e a una musicista, salirà un ospite diverso per ogni replica…
«Sono convinto che il teatro oggi debba tornare a essere un luogo di incrocio di saperi. C’è un’imbarazzante separazione del teatro dal corpo sociale e dal corpo civile. Aprirsi, incontrare l’altro è fondamentale. Non ci si deve chiudere su uno specifico teatrale ma pensare che uno scienziato piuttosto che un antropologo piuttosto che un pittore o un sociologo o un economista possa dire qualcosa di interessante per il teatro e in teatro possa trovare degli stimoli».
Si tratta quindi di testimonianze sull’idea di Europa?
«È un’intervista, un momento di snodo all’interno del corpo compatto dello spettacolo. Uno spettacolo costruito per sequenze tematiche, otto, dove la quinta sequenza è quella delle guerre, che chiude la prima parte di riflessione sull’Europa in senso lato. E non è un caso, perché il progetto della Ue nasce all’indomani della seconda guerra mondiale come tentativo di risposta a quella che Toniolo definisce ‘la seconda guerra dei trent’anni’ che inizia nel 1914 e finisce nel 1944. Perché di fatto prima e seconda guerra mondiale sono un grande blocco, che ha distrutto un’idea di Europa, nel senso che nel mondo della Felix Austria l’Europa è vera, si parlano due, tre lingue, c’è un’abitudine a girare, per Cechov è normale andare a Parigi piuttosto che finire a Baden, c’è un mondo europeo che crolla dopo la prima e dopo l’ulteriore devastazione della seconda guerra mondiale».
Uno sguardo a ciò che eravamo in considerazione di ciò che possiamo essere?
«Il sottotitolo dello spettacolo – per un’archeologia dei saperi comunitari – è un omaggio a Foucalt, perché c’è un confronto con un certo tipo di storia che Foucault chiama archeologia appunto. Il nocciolo è uno sguardo su quello che è stato, che ci interessa per quello che è e per quello che sarà. Il tema scelto sta tra l’urticante e l’indifferente. La partenza all’università non è stata certo entusiasmante, per un ragazzo di oggi l’Europa è l’euro, è la troika, è lo spread. C’è un prurito nei confronti della tematica europea, e anche una situazione di ignoranza diffusa, lo dico senza nessun disprezzo, perché fino al 2012 anche io ero profondamente ignorante sul tema».

Foto Giuseppe Distefano
Quindi il ratto ha anche lo scopo di creare una coscienza?
«Di attivare una sensibilità o una riflessione. Non ho pensato questo progetto in termini europeistici o filoeuropeistici, non mi sento vincitore se chi ha preso parte al Ratto decide di votare il Parlamento Europeo, sono anche contento se qualcuno finisce per votare Le Pen, se lo fa operando una scelta».
Un progetto tentacolare. Un tema politicamente, economicamente, socialmente, culturalmente complesso. Ma affrontato con ironia…
«L’assunto di fondo è portare a teatro chi normalmente non va, e questo ha significato ricercare un vocabolario comune, parlare il linguaggio della parodia, della comicità, del riso in termini realistici. Mi rifaccio alla riflessione di Brecht sul teatro di insegnamento e teatro di divertimento, secondo cui il teatro è teatro di insegnamento, ma proprio nella misura in cui è teatro deve essere teatro di divertimento. Inoltre, dice sempre Brecht indicando il comico come la via che porta a un contatto vero con la realtà e non a un contatto sublimato o edulcorato verso cui porta la commedia, la tragedia più della commedia prende alla leggera le sofferenze dell’umanità».
Intervista a cura di Rossella Porcheddu