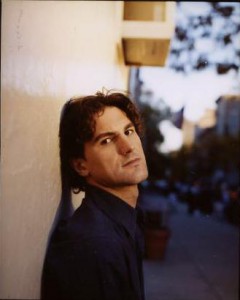Le note di Gianfranco De Franco calano il sipario sulla XIV edizione della Primavera dei Teatri. È l’alba. Una trentina di impavidi assistono tra sonno e veglia alla performance Volo infermo del musicista cosentino. Raccolti nell’atmosfera mistica delle colonne del Protoconvento Francescano, location storica della rassegna. De Franco fa suonare una dozzina di strumenti, elettronici, tradizionali, popolari. Lo accompagna nell’esecuzione Ilaria Montenegro, un’artista di questa terra. Con la A maiuscola. Passano 45 minuti di proiezioni e musica. Proiezioni altrove – non solo una questione di sonnolenza – di ipnosi, piuttosto. I suoni catalizzano sensazioni, umori, esperienze, dejavù delle giornate trascorse tre le poltrone del teatro e le frivolezze dell’ante e post festival. Una grossa edizione. Per numeri, qualità, portate servite. Uno dei pochi festival in cui la scuderia della critica si ritrova in massa. L’unica manifestazione che fa parlare della Calabria artistica, in campo teatrale. L’unico modo per pensarci mitteleuropei, o almeno mediterranei. Uno dei padroni di casa chiude la rassegna sul palco. Dario De Luca e il suo concerto-spettacolo Morir sì giovane e in andropausa messo su con Giuseppe Vincenzi, un’altra eccellenza di questa terra in quanto a mente. Suonato dalla Omissis Mini Orchestra e documentato ampiamente da critica e cronaca.
Chiusura dell’ultima giornata di spettacoli tra fischi e fiaschi. Il fiasco Simone Biggi: no comment. Basta dire che in corso d’opera una trentina hanno abbandonato la platea. Composta da critici per lo più. I dieci minuti di flatulenze, dal palco, indicano la caratura dell’allestimento big biggi one man show.
Prima serata per le Fibre Parallele e l’anteprima nazionale di Lo splendore dei supplizi. I pugliesi confermano la loro vocazione scenica. Visivamente minuziosi, nelle meccaniche dei gesti e dei movimenti sul palco, drammaticamente maturi con margini di sviluppo esponenziali, chiaroveggenti nel creare e prevedere il responso degli uditori. Quattro quadri, microatti, ognuno con un vizio da scontare. Un languore di coppia, una disonestà reiterata, il razzismo, l’ineguaglianza. Quattro scene per quattro supplizi. Ma in platea tutt’altro. Piacere. La pluripremiata compagnia testimonia la sua genetica teatrale. Senza acrobazie tecniche o psicofisiche, un lavoro di indagine sull’attuale, proposizione di evergreen in contesto di cancri sociali, artigianalità teatrale e sapienza nella speculazione spaziale. Un lavoro ‘scientifico’, di quella scienza artistica che è astrazione e concretezza. Dinamicità e sospensione. Concetto e pura forma. Drammaturgie di linguaggio d’uso e poetiche ricamate, nitidezza registica, sincronismo attoriale individuale e di coppia. Centotrentacinque minuti che sembrano venti…
Altra ciliegina lo spettacolo della sera precedente, venerdì, di Davide Iodice. Altra conferma. Di uno sguardo al teatro in sembianze altre. Uno sguardo dalla platea su qualcosa di evanescente, eppure frutto di moti, tempeste interiori, materializzate con la levità del passo coreografico, la poesia visiva della danza. E del gesto osmotico. E dell’estetica che diventa materia. L’elemento naturale che tra le pareti del palco diventa impercettibile. La prima nazionale di Mangiare e bere. Letame e morte, con Alessandra Fabbri e tutto il resto di Iodice (regia, drammaturgia, spazio scenico, luci), divide la platea. Se piace sublima, se non piace è ritenuto plastico, finto, edulcorante. Ci si domanda come può un travaglio viscerale risultare finto, quando dell’attrice si avverte il respiro che inciampa tra i denti nell’azione drammaturgica e se ne percepisce la liberazione quando il gesto danzante la muove. Se ne percepisce la vibrante sensazione di leggerezza provata nell’esecuzione, per consegnare quello che non si riesce con le parole, metafora di incomunicabilità contemporanee. Un’indagine sull’animalità dell’attore, sull’istinto animale di stare sul palco come predestinazione, come habitat, l’unico possibile probabilmente. E tutto, nel suo codice di simbolismo, appare chiaro e intellegibile. Soggetto anche a interpretazioni, come tutto ciò che arte lo è. Non è possibile standardizzare, nemmeno comporre decaloghi o istruzioni d’uso sul fare scenico. Se si giunge a questa deriva è per il marcio esercizio di un presunto potere. Di chi osserva, soprattutto. Un osservatore aperto mentalmente è già di per sé un privilegiato. Il suo sguardo vede oltre e dovrebbe intermediare, con l’esperienza e le competenze, verso chi ha la vista corta perché non assiduo di luoghi teatrali o semplicemente per attitudine diversa. Non ci sono spettatori di serie A e serie B, ci sono coloro che stanno sul palco e quelli che stanno dall’altra parte. Alcuni più attenti, esperti, curiosi di altri. Invece c’è chi sta in platea come fosse seduto su uno scranno d’Olimpo. Pratiche malsane. Il sapere si diffonde, non si agita come fascio littorio.
Visto a Primavera dei Teatri, Castrovillari
Emilio Nigro