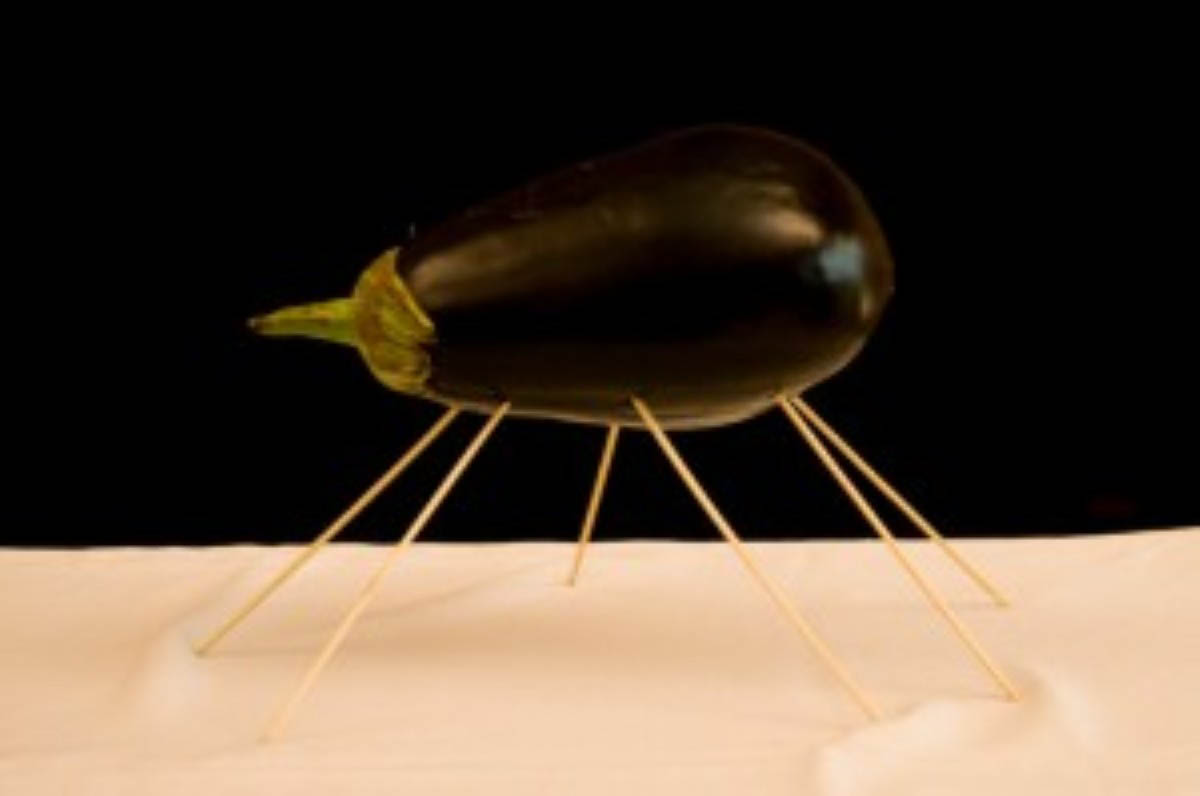Recensione a La notte poco prima della foresta – Claudio Longhi / Mimesis
Fatti accedere negli umidi ambienti sotterranei del Bastione Alicorno, gli spettatori giunti a vedere La notte poco prima della foresta di Bernard-Marie Koltès, prendono autonomamente una sedia e si dispongono a piacere all’interno dell’ambiente proposto. L’impronta registica di Claudio Longhi – che con questo spettacolo dà inizio al ‘Progetto Koltés’- è fin da subito d’impatto: il pubblico seduto e in attesa, senza un palco cui convogliare gli sguardi, viene scosso da un incipit di rissa finito in una secchiata d’acqua lanciata addosso a colui che, ben presto, si capirà essere il protagonista. Il giovane ( interpretato da Lino Guanciale) prova a spiegare, raccontarsi, abbordare un pubblico incuriosito e stupito soprattutto di trovarsi immerso nelle sue elucubrazioni vaneggianti; lo strano ragazzo si rivolge loro faccia a faccia, in una vicinanza fisica inusuale rispetto agli spazi di fruizione teatrale tradizionali. Durante il racconto, alcuni spettatori diventano interlocutori privilegiati, occhi negli occhi con il protagonista, che , al contempo, si rivolge all’intero pubblico, che si sente , quindi, interamente coinvolto dietro al “tu” che gli rivolge il giovane.
Il luogo non è l’ambientazione prevista, infatti all’originario bar all’aperto del Bastione Santa Croce è stato preferito un ambiente chiuso – immune quindi dai pericoli del maltempo sempre in agguato. Probabilmente nell’atmosfera mondana di un luogo di ritrovo in cui il pubblico è riunito in situazione di convivialità comune, ma seduto a dei tavolini a creare unità indipendenti, la relazione con quest’individuo, così istintivamente invadente, avrebbe forse avuto maggiore impatto.
Il giovane è un individuo che appare instabile, a tratti infervorato e soprattutto rapito dalla necessità di esprimere ciò che ha dentro, ma che non riesce a dire fluidamente e completamente fino alla fine. Emerge il tema del “diverso”, – ancora una volta uno straniero non voluto – il tema dell’individualità incompresa, con un’attenzione politica al rapporto tra società e solitudini marginali che è insito nel testo scritto nel ’76 dal drammaturgo francese. Il brano, tanto divagante, vario, ma legato aripreseda stessi temi e fili conduttori, è in realtà un’unica lunga frase priva di punteggiatura, un flusso di pensieri che riesce a contenere al suo interno racconti, mondi, relazioni, ricordi, speranze.
Dell’intenso spettacolo rimane nella memoria lo sguardo di un ragazzo che ha sete di comunicare, che ha sete di incontro: i suoi occhi sono calamite imploranti, alla ricerca di agganciare attenzione, ascolto, amore. Indimenticabili la frenesia e il costante corpo fradicio dell’attore che – a puntuali riprese – subisce cariche d’acqua che gli impediscono di asciugarsi, riportandolo ad un costante stato di inzuppamento fresco da pioggia.
Agnese Bellato