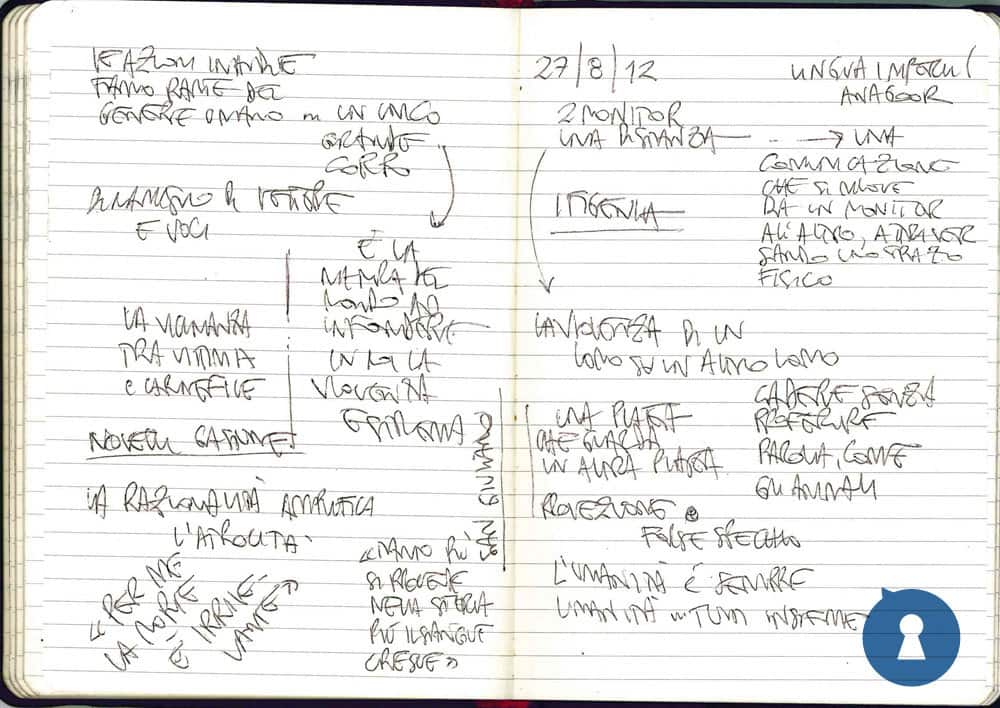Dopo lunga attesa è approdato sul palcoscenico del Teatro India di Roma Sweet Home Europa (8-26 aprile 2015), drammaturgia pluripremiata del milanese trapiantato in Catalogna Davide Carnevali. Dal 2011, anno della composizione, e dopo diverse versioni europee e sudamericane del lavoro, l’opera ha trovato in Fabrizio Arcuri l’artefice della messa in scena italiana, prodotta dal Teatro di Roma. Lo spettacolo, così come la drammaturgia su cui si fonda, si snoda in dodici quadri ed esplora, immergendo le situazioni e i personaggi in un’indeterminatezza inquietante e ambigua, la complessità e la criticità dell’edificazione di un’identità europea. La frammentazione del continente riflette le spaccature che lo sconvolgono: il problema dell’identità non si manifesta solo sul piano della sua definizione nazionale e continentale, ma su scala più universale – generazionale, sessuale, in relazione all’alterità – innescando meccanismi “esplosivi” che mettono alla berlina tutte le contraddizioni di un’Europa che vorrebbe essere “casa” ma che ancora fatica ad accogliere, integrare, porsi in rapporto con ciò che non conosce e non riesce ad assimilare.

Sweet Home Europa – foto di Valeria Tomasulo
Sweet Home Europa, prima parte di un dittico, debutta in Italia ad aprile 2015, ma ha alle spalle un ricco percorso scenico internazionale. Com’è nato il testo e qual è stato il suo itinerario fino a questo momento?
Davide Carnevali – L’idea di testo è nata 5-6 anni fa, nel 2009-‘10. All’epoca vivevo a Berlino e mi interessava molto il problema dell’Europa dal punto di vista della costruzione di un’identità europea al di là di quelle nazionali, lo scontro di culture e quello linguistico: erano questi i temi che volevo affrontare. Contemporaneamente stavo iniziando un percorso creativo con il sistema teatrale tedesco: avevo vinto nel 2009 un premio al festival Theatertreffen, che, come struttura, mi ha seguito, interessandosi a ciò che stavo scrivendo. Così, abbiamo intrapreso un itinerario comune, assieme al mio editore tedesco, Rohwohlt, e alla mia traduttrice. Nel 2011 – anno in cui il testo è arrivato finalista al Premio Riccione Teatro – il Theatertreffen mi ha proposto di presentare il lavoro come mise en éspace al Festival Internazionale di Letteratura di Berlino. Nel 2012 la Schauspielhaus di Bochum, che stava programmando un progetto sull’Europa, ha scelto di produrre il mio testo. Nello stesso anno la Deutschlandradio Kultur, la radio nazionale tedesca, che aveva già fatto un adattamento della mia opera precedente, Variazioni sul modello di Kraepelin, ha adattato anche Sweet Home Europa in forma di radiodramma, diretto da Giuseppe di Maio. Nel 2013 ha avuto luogo la lettura scenica dell’opera al Théâtre du Vieux-Colombier di Parigi da parte della Comédie Française e in Argentina, al ELKAFKA espacio teatral di Buenos Aires, abbiamo portato in scena lo spettacolo.
Dunque, pare che, per un autore italiano, sia più lineare scrivere, produrre e far circolare i propri lavori all’estero, rispetto a quanto accade in Italia.
D. C. – Il sistema tedesco funziona bene per gli autori perché non si vince un premio e si viene “abbandonati”, ma si viene seguiti nel percorso; è un pò quello che adesso stiamo tentando di fare con il Premio Riccione qui in Italia. Quando ho scritto questo testo, inoltre, sapevo che sarebbe stato rappresentato prima in Germania, che avrebbe quindi dovuto avere un respiro internazionale; ero consapevole che per me l’Italia non era più il principale mercato su cui puntare, per cui ho cercato di scrivere un’opera che potesse essere universalmente accettata, che potesse essere interessante anche in contesti culturali molto diversi da quello che ho io come riferimento.
E l’arrivo in Italia come è avvenuto?
Fabrizio Arcuri – L’approdo al palcoscenico romano ha avuto origine, guarda caso, in Francia. Con Davide ci siamo conosciuti nel 2011; ci trovavamo a lavorare per motivi diversi al festival Écrire et mettre en scène aujourd’hui a Caen, in Normandia. Ci frequentavamo: ho letto i suoi testi e Sweet Home Europa mi aveva particolarmente incuriosito per le sue potenzialità sceniche, così, nel 2013, in occasione del festival dedicato alle nuove drammaturgie Tramedautore, al Piccolo Teatro di Milano, ho curato una mise en éspace che a Davide è parsa interessante. Da quel momento ho cercato fortemente una produzione, che il Teatro di Roma ha sostenuto, per realizzare l’intero lavoro che abbiamo presentato in prima nazionale al Teatro India lo scorso 8 aprile.

foto di Valeria Tomasulo
Quindi Sweet Home Europa, per lo meno nella sua versione italiana, è un lavoro condiviso, in cui drammaturgo e regista hanno incrociato costantemente i propri percorsi durante il processo creativo che ha portato alla messa in scena?
F. A. – Non direi, abbiamo condiviso alcune fasi, ma lo spettacolo si è generato autonomamente rispetto al suo autore. Davide si pone nei confronti delle sue opere in maniera autorale: consegna il testo a chi dovrà tradurlo in scena, lo affida e questo lo si intuisce dalla natura stessa della sua scrittura. Ci sono stati momenti di confronto e poi Davide aveva già visto la mise en éspace milanese e in quell’occasione ne avevamo parlato, avevamo individuato una direzione comune. La cosa bella è che Sweet Home Europa di Davide può essere trattato come un classico: è molto strutturato e la relazione tra tutti gli elementi della struttura è chiara, non c’è nessuna falla, il testo non ha bisogno di integrazioni: letterariamente è in perfetto equilibrio, le ambiguità, le iterazioni e le variazioni, le aperture sono sempre pertinenti, non necessitano di nessun intervento ulteriore per essere rese intelligibili.
Sweet Home Europa affonda il suo nucleo fondamentale nel tema dell’integrazione (im)possibile, in prima battuta nell’Unione Europea e, nella voluta ambiguità del contesto, anche su scala più ampia. Visti gli accadimenti tragici di questi giorni legati alle migrazioni e al dibattito sull’accoglienza, il testo pare di cogente attualità ed urgenza.
D. C. – Credo che questo testo sia sempre stato urgente; nel momento in cui lo scrivevo era prioritaria la questione della ratificazione della Costituzione Europea da parte dei Paesi membri. Il tema, da migrante intereuropeo, mi stava molto a cuore. Questi argomenti – le migrazioni, l’accoglienza, l’integrazione – trascendono la contingenza storica e sul lungo periodo si rivelano sempre attuali. Indubbiamente, sembra che il testo sia stato scritto in un dato momento, per una data situazione, ma non è così. Due anni fa, come dicevo, è stato fatto un allestimento del lavoro in Argentina e anche là è risultato attuale, per ragioni però diverse da quelle per cui risulta attuale oggi, qui a Roma.
Il testo si articola in una struttura complessa, scandita in dodici quadri, attraverso i quali i personaggi, in perenne transizione da un ruolo a un altro, spesso antitetico, attraverso un uso della lingua calibrato, che spesso riprende immagini scritturali, genera un’ambiguità profonda, crea spaesamento e pare opporre due diversi sistemi di pensiero – quello occidentale, spiralizzato in astrazioni e concettualizzazioni, e per opposizione quello di matrice non razionalista, concreto, aderente alla realtà delle cose, che trova il suo emblema nella “parabola” del branzino, che del resto, mette in circolo un simbolo cristologico.

foto di Valeria Tomasulo
D. C. – Il problema di fondo è quello dello scontro di culture, fra quella europea in opposizione a quella extraeuropea, ma proprio a partire dal conflitto identitario all’interno dell’Europa stessa. Preferisco che i personaggi vengano individuati sulla base del potere che detengono (quindi, nel caso dei personaggi maschili della pièce, uno lo ha, l’altro no – il personaggio femminile non ha mai potere), che non su quella della provenienza (europeo vs. non europeo); il loro rapporto è mantenuto ambiguo proprio per questo. L’ambiguità identitaria è quello che cercavo nel momento in cui vincolavo questi contenuti alla loro forma testuale, nella determinazione di chi è il personaggio e di quanti sono i personaggi. Essa è necessaria per mostrare a livello formale l’ambiguità delle identità, della loro costruzione. Il potere di cui parlo è un potere in primo luogo linguistico: noi vediamo il mondo come lo esprimiamo nel linguaggio. O meglio: esiste un’omologia strutturale tra come esprimiamo il mondo nel linguaggio e come lo interpretiamo. Il potere che ha in mano l’uomo è primariamente un potere linguistico, prima ancora che economico, di prestigio sociale o politico. Chi ha più potere linguistico ha in mano la “chiave” per imporre la propria visione del mondo, che diviene così egemonica. Il linguaggio è il discrimine che differenzia una cultura dominante da una minoritaria. Ciò che desideravo – desideravamo – era recuperare la minoritarietà, parificarla con la cultura dominante, mostrare come il rapporto tra minorità e maggiorità è solo una costruzione artificiale, un’immagine che si impone come imperante rispetto a un’altra. Ovviamente entrambe sono valide: volevamo recuperare la validità e le contraddizioni di entrambe. L’ironia è poi sempre presente a controbilanciare la tensione e la gravità tematica di molti passaggi: il testo è complesso ma desideravo che arrivasse al pubblico in modo leggero.
Però la regia, pur mantenendo l’ambiguità, ha fatto delle scelte precise. In uno dei quadri appare una donna velata, che dialoga con il figlio emigrato e la rottura tra i due pare ormai radicale e insanabile. Mi è parso che il riferimento all’Islam fosse palpabile.
F. A. – Non potrebbe essere sarda, la donna?
D. C. – Credo che quel velo sia molto ambiguo, in realtà. Mi è parsa una buona scelta registica: ricorda l’Islam, certo, ma anche il Sud, o l’Ucraina e la Lituania, che sono stati tra i primi Paesi ad essere cristianizzati.
Scrivi nell’introduzione al lavoro che gli spunti alla base del testo sono due discorsi pubblici, per molti versi ideologicamente agli antipodi, in cui l’Europa viene definita “casa”. Il primo è quello tenuto da Michail Gorbaciov davanti al Consiglio d’Europa nel 1998, il secondo è quello tenuto nel 2009 da papa Benedetto XVI davanti al rappresentante della Commissione delle Comunità Europee, presso la Santa Sede. Nell’opera, così come nella sua regia, pare però che questa “casa” europea non regga l’impatto della differenza, che imploda su se stessa e si riduca a un cumulo di macerie.
D. C. – Riguardo al concetto di Europa come “casa” mi sono riferito sia a questa definizione del continente data da Gorbaciov nel ’98, sia all’accezione impiegata anni dopo da Ratzinger, quindi dell’idea di un continente che possa offrire protezione. La casa ha porte che possono aprirsi o chiudersi, a seconda di quali siano le nostre intenzioni rispetto a ciò che c’è al di fuori. Come vogliamo che stiano le porte del nostro continente? Questa è la grande domanda. Ovviamente le connotazioni della metafora, in Gorbaciov e Benedetto XVI, erano diverse, antitetiche: per la situazione politica e la storia personale di Gorbaciov, egli si riferiva ad apertura positiva, mentre Ratzinger era interessato alla difesa delle radici cristiane dell’Europa, a una casa votata alla conservazione di una tradizione precisa. Un’immagine egemonica, quella dell’Europa cristiana: è innegabile che il cristianesimo abbia influenzato la cultura occidentale ed europea, ma il pensiero cristiano si basa in larga parte sulla filosofia platonica, neoplatonica ed aristotelica ed è quindi a sua volta la rielaborazione di una stratificazione precedente. Siamo a Roma, città costruita su macerie e stratificazioni di pensiero e civiltà differenti: è interessante proporre qui la questione.

foto di Valeria Tomasulo
F. A. – Con la mia regia, ho cercato di dare corpo ai diversi livelli messi in atto dal testo. Il nostro compito non è quello di avere una comprensione globale esterna: questo nel lavoro pratico quasi non serve. Abbiamo cercato, dal di dentro, a partire dalla parola, di fare il percorso inverso, per restituire quello che è un umore, un’atmosfera testuale, che si comprende nella lettura complessiva. Entrando nel testo ci siamo resi conto che esso procedeva su tre livelli: la narrazione circolare, che mette in gioco parole e concetti che rielabora costantemente da punti di vista diversi, sviluppando quindi processi diversi nelle relazioni tra i gli attori. Le parole sono più o meno le stesse ma attualizzano possibilità sempre differenti per i personaggi, che reagiscono nella relazione in maniera diversa rispetto a quando le stesse parole erano proferite da altri, in altre situazioni. Il secondo livello è meta-teatrale: Davide parla direttamente allo spettatore consegnandogli delle chiavi di lettura; con un artificio drammaturgico presenta, per esempio nella scena 3 e 4 (in cui due personaggi più maturi, che incarnano la coscienza collettiva, si rivolgono al più giovane, ndr), mette in atto gli aspetti secondo i quali ha deciso di affrontare il testo: quello letterale, quello allegorico, quello simbolico, fornendo le chiavi con cui stare dentro al testo, che passa di continuo da una macro-storia a una micro-storia, individuando il precipitato della macro nella micro. Il terzo livello è quello delle didascalie, in cui la relazione con lo spettatore è diretta, narrativa: Davide racconta il paesaggio che si trasforma di continuo, nello sviluppo delle varie vicende, disgregandosi lentamente, sbriciolandosi in macerie, inaridendosi in una progressiva desertificazione. Registicamente, ho tenuto ben presenti questi livelli, attribuendo a ciascuno di essi la responsabilità di ciò che dovevano raccontare. Alla scenografia, realizzata da Enrico Gaudi e Riccardo Dondana (3tolo), ho deciso di attribuire il compito di raccontare il livello didascalico.
La musica dal vivo, eseguita da Davide Arneodo e Luca Bergia (Marlene Kuntz) con NicoNote alla voce, è un altro elemento di novità. Come avete costruito il dialogo con la musica e la drammaturgia musicale?
F. A. – L’idea di utilizzare la musica è suggerita dal testo, nel quale sono presenti didascalie in cui Davide asserisce “in questo momento sarebbe opportuna una musica cataclismatica” o “niente sarebbe meglio di una musica celestiale”, quindi indirizza verso uno specifico “ascolto” musicale. In questo spettacolo era possibile lavorare sull’aspetto sonoro perché l’autore stesso gli attribuiva una posizione specifica nello spettacolo, una potenzialità scenica, per permettere un passaggio nell’umore dello spettatore. Lo spettacolo è fatto di 12 quadri: volevo evitare però che la performance dal vivo dei musicisti si riducesse a un siparietto, a un automatismo di transizione, per cui ho lasciato alcune didascalie testuali, proiettate sulla scenografia, affinché rivelassero l’intenzione dell’autore, alternandole con la produzione dei musicisti. Arneodo, Bergia e NicoNote hanno fatto un pò di prove con noi, poi hanno lavorato e composto in autonomia. In seconda battuta, ho sentito la necessità che i pezzi fossero cantati, perché essendo canzoni a sé stanti non fungevano da colonna sonora ma da brani indipendenti. Le parole delle canzoni parlano del testo stesso e in alcune occasioni sono mutuate direttamente da esso. Diciamo che le canzoni, le loro parole, sono trascurabili ma allo stesso tempo, se il loro senso viene afferrato perché si conosce la lingua o si percepisce il significato (sono in inglese, ndr), riportano alla drammaturgia, ai suoi significati.
Come abbiamo visto, Sweet Home Europa è la prima parte di un dittico. Possiamo avere qualche anticipazione sul testo che seguirà?
F. A. – Davide ha appena finito di scrivere la seconda parte del dittico che avremmo voluto portare in scena con Sweet Home Europa ma non è stato possibile. La rimanderemo a più avanti, qui in Italia, per lo meno, intorno al 2017, speriamo!
D. C. – I due testi – Sweet Home Europa e la nuova opera – sono indipendenti, ma avevo concepito i lavori come in sequenza: il primo, questo, è sulla genesi dell’Europa, partendo da una rielaborazione di materiale testuale biblico relativo ai primi libri del Testo Sacro (Genesi, Esodo), mentre la seconda parte sarà incentrata sulla fine dell’Europa e sarà un rimaneggiamento dell’ultima parte della Bibbia, il Nuovo Testamento, i Vangeli e l’Apocalisse. Tratterà quindi della crisi dell’Europa, economica, d’identità nazionali e transnazionali; ci saranno animali, personaggi ambigui, ma sarà piuttosto diverso da Sweet Home Europa. Si intitola Lost Words.
Intervista a cura di Giulia Morelli













 Una porzione di palco. Due pareti che s’incontrano a formare un angolo. Uno spazio bianco. Due uomini e due donne che lo abitano. Senza mai mostrare il volto, senza mai svelare il mistero. Possiamo vederli ma non riusciamo a riconoscerli. Possiamo guardarli ma non definirli. Abiti dai colori tenui. Movenze leggere. Parole poetiche. Immagini raffinate. Quello che di più grande l’uomo ha realizzato sulla terra di
Una porzione di palco. Due pareti che s’incontrano a formare un angolo. Uno spazio bianco. Due uomini e due donne che lo abitano. Senza mai mostrare il volto, senza mai svelare il mistero. Possiamo vederli ma non riusciamo a riconoscerli. Possiamo guardarli ma non definirli. Abiti dai colori tenui. Movenze leggere. Parole poetiche. Immagini raffinate. Quello che di più grande l’uomo ha realizzato sulla terra di